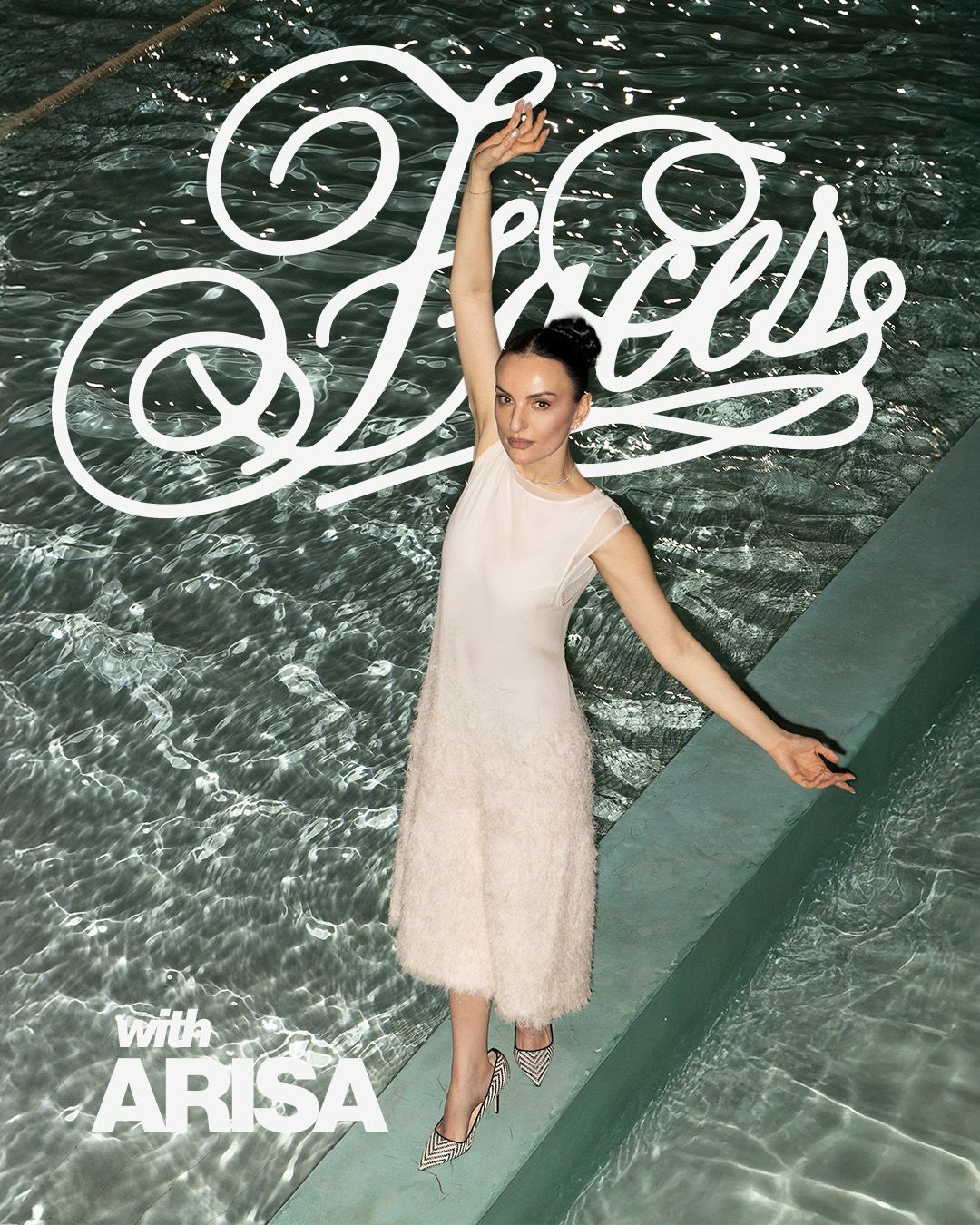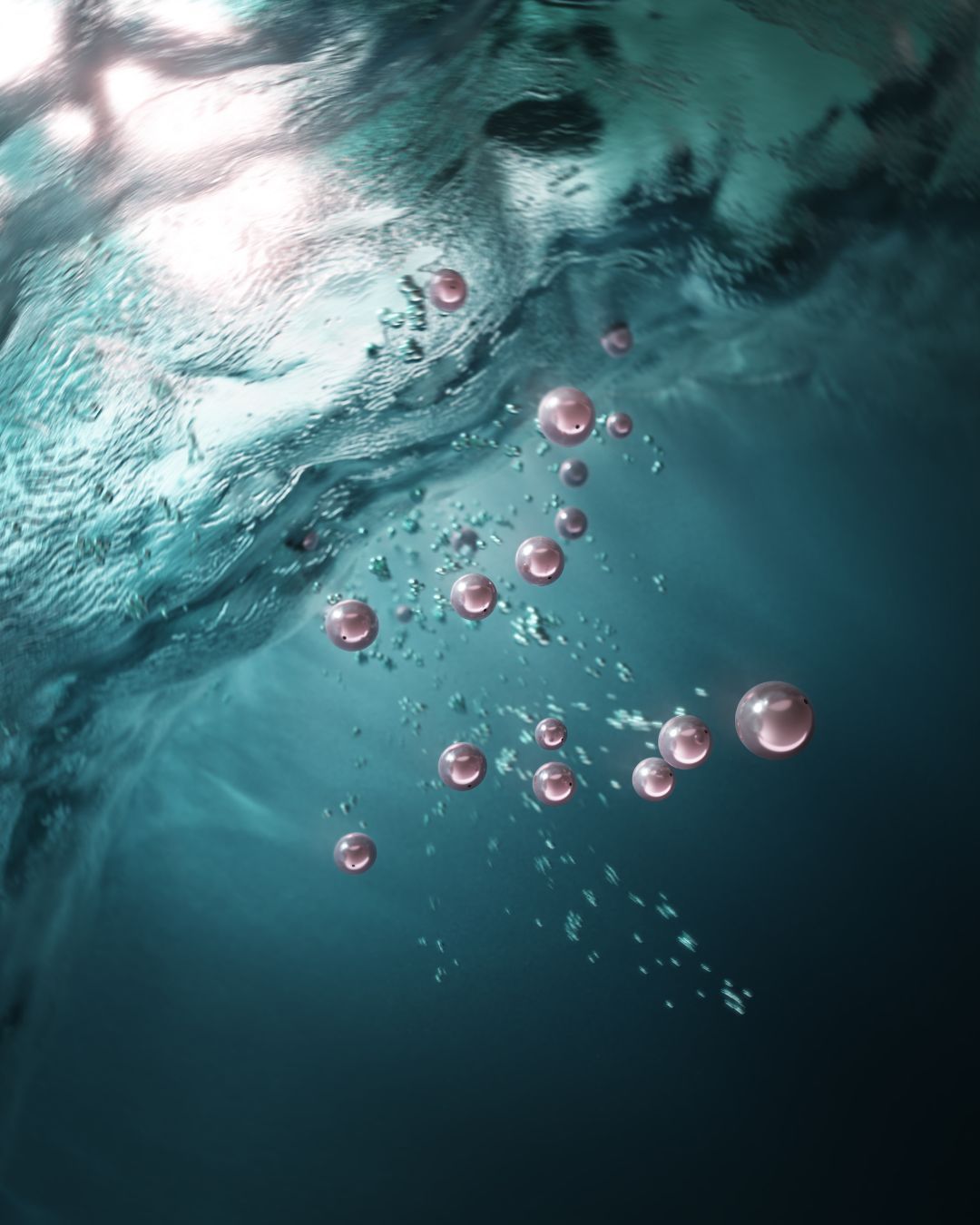Benvenuti nell’era del character dressing Appunti sull’dentità prêt-à-porter. Ossia dimmi chi interpreti e ti dirò chi sei

Vestirsi, in fondo, non è mai stato un gesto neutro. Anche quando abbiamo finto che lo fosse, anche quando lo abbiamo ridotto a una questione di praticità o di buon gusto, l’abbigliamento ha sempre funzionato come una dichiarazione silenziosa. Da sempre, o quasi, scegliamo cosa indossare per raccontare chi siamo, chi stiamo cercando di diventare o, più segretamente, chi vorremmo essere. È un linguaggio, un sistema di segni che parla prima ancora che apriamo bocca. Attraverso i vestiti abbiamo raccontato i nostri gusti, le nostre ossessioni, le nostre letture, i film che ci hanno cambiato la vita, gli artisti che hanno influenzato il nostro modo di stare al mondo e che ci hanno fatto sentire meno soli. Dai punk ai mod, dai grunge ai ravers, dai goth agli indie sleaze ante litteram, vestirsi è stato a lungo un atto di riconoscimento reciproco, un modo per appartenere. Non si trattava solo di estetica, ma di valori, di posture politiche, di visioni del mondo. L’outfit era una frase complessa, stratificata, spesso imperfetta, ma sincera. Oggi, invece, qualcosa sembra essersi spostato. La profondità narrativa dell’abito sembra assottigliarsi, sostituita da una performance continua, da un’estetica che vive soprattutto per essere vista, condivisa, validata. È in questo cortocircuito tra racconto e superficie, tra appartenenza e visibilità che prende forma il character dressing contemporaneo.
L’identità come ruolo: dalla costruzione al casting
Il character dressing consiste nel vestirsi come un personaggio che si immagina, si desidera o si aspira a essere. In sé, non è una novità. Abbiamo sempre usato i vestiti per sperimentare versioni alternative di noi stessi. La differenza, oggi, sta nel modo in cui questi personaggi vengono costruiti Se prima il personaggio nasceva da un mondo interiore fatto di riferimenti culturali, esperienze e appartenenze reali, ora spesso sembra costruito a partire dall’esterno, come una maschera pronta all’uso. L’identità diventa prêt-à-porter non solo perché indossabile, ma perché facilmente sostituibile. Un personaggio al giorno, un’estetica a rotazione, una moodboard che cambia con l’algoritmo. Il guardaroba si trasforma così in un archivio di maschere, più che in una collezione di storie vissute. Non è la molteplicità a essere problematica, è sempre stata una ricchezza, ma la mancanza di radicamento. Quando ogni personaggio è intercambiabile, nessuno lascia traccia.
Dal method dressing al character dressing
Il red carpet ha avuto un ruolo fondamentale in questo slittamento. Il method dressing, ovvero la pratica di vestirsi in continuità con il personaggio interpretato in un film anche durante il tour promozionale si è trasformato nel tempo uno strumento iper-consapevole di comunicazione, una leva di marketing, un generatore di meme, un contenuto pensato per vivere su TikTok e Instagram più a lungo dell’opera stessa. Da Margot Robbie a Zendaya, fino a Timothée Chalamet, l’abito non accompagna più la narrazione, ma spesso la anticipa, la sostituisce, la amplifica fino a renderla secondaria. Questa logica, una volta interiorizzata, ha iniziato a filtrare nella vita quotidiana producendo un effetto collaterale evidente: iniziamo a vestirci come se fossimo sempre in promozione di qualcosa. Di noi stessi, della nostra immagine, della nostra brand identity. Il character dressing si inserisce perfettamente in questo meccanismo per il quale il personaggio non deve essere vero, basta solo che sia efficace. Peccato che quando tutto è costruito per funzionare a colpo d’occhio, per essere decodificato rapidamente, la complessità sia un ostacolo.
Uniformi senza comunità
In un’epoca in cui le identità sono frammentate, fluide e spesso sovraccariche, la moda risponde con il ritorno delle uniformi. Sailorcore, giacche militari, codici utilitaristici, armature simboliche. Vestirsi come parte di un gruppo, reale o immaginato, racconta un bisogno profondo di struttura e appartenenza. Ma c’è una differenza cruciale tra indossare un codice perché lo si vive e indossarlo perché lo si riconosce. Un tempo, vestirsi punk implicava una presa di posizione, un rischio sociale, una scelta di campo. Oggi, spesso, basta conoscerne l’estetica. Il character dressing contemporaneo produce sottoculture senza comunità. I segni sono corretti, i riferimenti riconoscibili, ma manca l’attrito. Non c’è conflitto, non c’è durata, non c’è investimento emotivo. L’uniforme è un guscio visivo che promette un’appartenenza simulata, rassicurante, facilmente disattivabile. Non unisce, decora.
Moda e Gen Z: archetipi ovunque, significati in dissolvenza
Le ultime fashion week somigliano ad un enorme casting aperto pieno di personaggi. (avete presente la prima collezione di Demna come nuovo direttore creativo di Gucci?) Il piratecore di Dior e di McQueen, il rococò di Erdem, il sailorcore di Duran Lantink x Jean Paul Gaultier, lo stile napoleonico di Ann Demeulemeester, l’estetica della moglie tradizionale riletta da Miu Miu sono archetipi forti, carichi di storia, che però rischiano di diventare semplici costumi se scollegati da un’esperienza reale. Il problema non è giocare con i codici, ma farlo senza interrogarsi su cosa stiamo realmente comunicando. Il character dressing, in questa versione, è una sequenza di maschere che non lasciano memoria. La Gen Z, che vive immersa in un flusso continuo di immagini, riferimenti, micro-estetiche, ha interiorizzato questa logica meglio di chiunque altro. Il suo linguaggio visivo è rapido, ironico, stratificato, volutamente chiassoso, ironico, nostalgico e profondamente radicato nella cultura online. Il rischio? Trasformare l’identità in un loop performativo, sempre aggiornabile, sempre provvisorio. Nel character dressing generazionale, l’outfit è spesso pensato per funzionare nello spazio bidimensionale dello schermo.
Tornare a vestirsi per dire qualcosa
Forse il 2026 sarà l’anno dello switch. Arriveremo ad un punto di saturazione, in cui l’estetica performativa perderà fascino e tornerà il desiderio di significato. Basta col character dressing inteso come escapismo superficiale. Smetteremo di chiederci se un outfit è instagrammabile e torneremo a chiederci se è significativo. Se racconta davvero qualcosa di noi, delle nostre ossessioni, dei nostri riferimenti culturali, del nostro modo di stare al mondo. Perché vestirsi, alla fine, ha sempre significato trovare un modo visibile per raccontare qualcosa di invisibile. E, forse, in un mondo che performa costantemente, la vera radicalità sarà indossare abiti che non cercano solo lo sguardo o l’approvazione immediata, ma dicono qualcosa di vero.